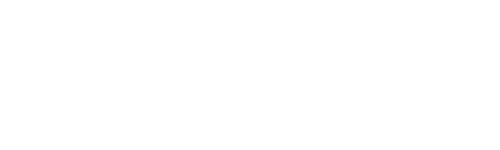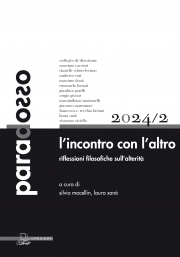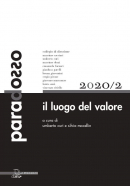Che cosa significa incontrare l’altro? Quali forme assume l’alterità – del corpo, del volto, del genere, del pensiero – nelle esperienze fondamentali dell’esistenza? L’altro ci precede, ci sfida, ci costituisce. Pensare l’alterità significa interrogare ciò che rende possibile l’etica, la relazione, la soggettività. Attraverso prospettive che spaziano dalla fenomenologia all’etica, dalla sociologia alla decostruzione, i saggi qui raccolti mettono in luce la complessità dell’alterità come categoria filosofica viva: la tensione tra attività e passività nella relazione, l’ambivalenza del desiderio, l’attenzione come apertura, la critica del binarismo sessuale, ma anche la questione della globalizzazione e della convivenza interculturale, in un mondo che si vorrebbe più connesso eppure disuguale. L’altro non si offre mai come realtà pienamente afferrabile; piuttosto, si manifesta come presenza inquieta e mobile, capace di incrinare le nostre certezze e rimettere in gioco il nostro modo di pensare e abitare la relazione. L’incontro con l’altro, allora, non si risolve: si abita. L’alterità si lascia intravedere come qualcosa che sfugge alla presa concettuale, talvolta come enigma che disorienta, talvolta come apertura vulnerabile che ci espone, altre volte come possibilità di accoglienza, ma anche come condizione del pensiero critico e dell’apertura all’altro-da-sé. In un tempo segnato da chiusure identitarie e conflitti culturali, questa raccolta invita a riscoprire nell’altro non una minaccia, ma la possibilità di una rinnovata umanità.
Paradosso. Rivista di filosofia, 2024/2
L’incontro con l’altro
Riflessioni filosofiche sull’alterità
Silvia Mocellin è professoressa associata di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università degli Studi di Padova, dove insegna Filosofia morale ed Etica e globalizzazione. Si occupa in
particolare di etica pubblica e applicata, con un’attenzione specifica alle tematiche dell’etica economica, dell’etica ambientale e ai dilemmi morali posti dalla società globalizzata. In quest’ultimo ambito, la sua ricerca si sviluppa lungo l’intersezione tra filosofia morale
e scienze sociali, con particolare riferimento, da un lato, all’antropologia economica, dall’altro, al dialogo interculturale. A questi temi sono dedicate alcune monografie e vari saggi: Il sogno poetico di un economista. L’antropologia economica di A. Sen, tra welfare economics ed economia dello sviluppo (FrancoAngeli, Milano 2005); Ripartire dalla vita buona. La lezione aristotelica in A. MacIntyre, M. Nussbaum e A. Sen (Cleup, Padova 2006); L’homo oeconomicus in evoluzione. Modelli antropologici e teoria della responsabilità sociale d’impresa (Bruno Mondadori, Milano 2011); L’uomo senza dimensioni. Spazio, tempo e cultura nella società globalizzata (Il Poligrafo, Padova 2012), e più recentemente, Il lavoro nel framework del capability approach: l’interpretazione di A. Sen («Lavoro, diritti, Europa», I, 2023); Una difesa liberale della vulnerabilità. Il buon vivere secondo Martha Nussbaum («La società degli individui», 76, 2023); Lavoro e agency: quale libertà nell’economia digitalizzata? («Iride», 2, 2023).
Laura Sanò è professoressa associata di Storia della Filosofia presso il Corso di Laurea in Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. È autrice di numerosi articoli e monografie sul pensiero filosofico contemporaneo. Oltre ad alcuni volumi dedicati alla tradizione del “pensiero negativo” (tra cui: Un daimon solitario. Il pensiero di Andrea Emo, La Città del Sole, Reggio Calabria 2001), ha pubblicato tre testi sul pensiero di Rachel Bespaloff: Un pensiero in esilio. La filosofia di Rachel Bespaloff, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007, di cui vi è una nuova edizione francese: Une pensée en exil. La philosophie de Rachel Bespaloff, Éditions Confèrence, Paris 2023; Su Heidegger, Bollati Boringhieri, Torino 2010; L’istante e la libertà, Einaudi, Torino 2021. Al problema della violenza, così come emerge nello specifico attraverso la prospettiva di tre figure particolarmente significative del pensiero femminile del ’900 (Weil, Bespaloff e Arendt), oltre che attraverso autori come Michelstaedter e Kafka, sono dedicati i volumi Leggere la Persuasione e la rettorica di Carlo Michelstaedter, Ibis, Como 2011; Donne e Violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del ’900, Mimesis, Milano 2012; Metamorfosi del potere. Percorsi e incroci tra Arendt e Kafka, Inschibboleth, Roma 2017.
Indice
PREFAZIONE
L’ALTRO COME INTERROGAZIONE
- Danielle Cohen-Levinas, Qui est l’autre? Quelques réfléxions sur la philosophie d’Emmanuel Levinas
- Andrea Bellantone, Distinti, non separati. L’alterità del corpo proprio come esperienza metafisica in Maine de Biran
- Stefania Tarantino, Simone Weil pensatrice dell’alterità
- Clementina Cantillo, Alterità e desiderio: alcune declinazioni
- Laura Sanò, Il prisma dell’attenzione. L’alterità nel pensiero di Simone Weil
IL FILO SOTTERRANEO DELL’ALTERITÀ
- Francesca R. Recchia Luciani, Le monstre hermaphrodite : la question du binarisme sexuel chez Michel Foucault et Jean-Luc Nancy
- Anna Ceschi, Dall’ambiguità costitutiva all’Altro assoluto: Simone de Beauvoir verso Il secondo sesso
- Edoardo Massimilla, «Agire sociale» e «relazione sociale». L’incontro con l’altro nella sociologia comprendente di Max Weber
- Valentina Surace, Manger l’autre. Jacques Derrida e l’eterofagia
- Silvia Mocellin, Non un «villaggio globale»: relazione, pluralismo e globalizzazione in Raimon Panikkar