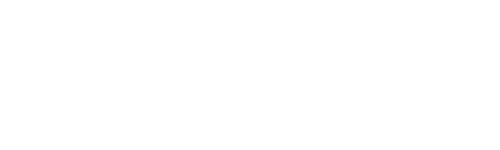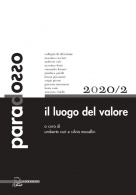Paradosso. Rivista di filosofia
Fondata nel 1990, «Paradosso» intende essere una rivista di filosofia, senza ulteriori specificazioni, per lo più debitrici ad effimere mode culturali, e senza arbitrarie suddivisioni disciplinari. Al centro di ciascun fascicolo è posta una tematica generale, corrispondendo a quel modo di concepire la scepsi che di fronte a un problema non pretende di fornire una risposta, ma invita piuttosto a “svilupparlo”.
La rivista è pubblicata dalla casa editrice Il Poligrafo dal 1997.
collegio di direzione: Massimo Cacciari, Danielle Cohen-Levinas, Umberto Curi, Massimo Donà, Emanuela Fornari, Bruna Giacomini (†), Gianluca Garelli, Sergio Givone, Massimiliano Marianelli, Giacomo Marramao, Francesca R. Recchia Luciani, Laura Sanò, Vincenzo Vitiello
comitato scientifico: Gérard Bensussan (Università di Strasburgo), Francesco Cattaneo (Università di Bologna), Claude Cazalé Bérard (Università di Paris X- Nanterre), Catherine Chalier (Università di Paris X- Nanterre), Rossella Fabbrichesi (Università degli Studi di Milano), Monique Jutrin (Università di Tel Aviv), Vivian Liska (Università di Anversa), Orietta Ombrosi (Università di Roma La Sapienza), Francesca Rigotti (Università della Svizzera italiana, Lugano e UZH - Universität Zürich), Carlo Sini (Università degli Studi di Milano), Stefania Tarantino (Università degli Studi di Salerno), Francesco Tomatis (Università degli Studi di Salerno), Claudio Tuozzolo (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara), Christoph Wulf (Università di Berlino)
segreteria di redazione: Giuseppe Armogida, Ludovica Boi, Lorenza Bottacin Cantoni, Jacopo Ceccon, Alberto Giacomelli (caporedattore)
La rivista attua la procedura di peer review per la valutazione dei contributi da pubblicare. Nella lista aggiornata all’11/11/2024 delle riviste scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, «Paradosso» compare accreditata nella Classe A, Area 11/C3 e 11/C5.
Norme redazionali:
– italiano
– english
CALL FOR PAPERS «PARADOSSO»: ALL’ALTEZZA DELLA VITA. GIUSTIZIA E DIRITTI NELLE FILOSOFE EBREE CONTEMPORANEE
Le proposte di contributo vanno inviate all’indirizzo redazione.paradosso@gmail.com entro il 30 dicembre 2025
Che cosa significa pensare la giustizia all’altezza della vita in un tempo in cui i diritti oscillano tra l’enunciazione di un universalismo astratto e l’esperienza concreta della loro fragilità, tra l’ordine delle costruzioni normative e l’esposizione irriducibile dei corpi? Il pensiero contemporaneo è chiamato ad abitare questa frattura, assumendola come luogo di interrogazione critica, in cui non è in gioco soltanto la forma delle istituzioni, ma il modo stesso in cui l’esistenza, nella sua vulnerabilità costitutiva, diviene spazio di rivendicazione, di responsabilità e di presa di posizione condivisa, sul piano teoretico, morale e politico.
Il presente fascicolo si colloca entro questo orizzonte e propone una riflessione sul nesso tra giustizia e diritti a partire dal contributo delle filosofe ebree del Novecento. In questi pensieri, la giustizia non si lascia ricondurre a una grammatica procedurale né a una legalità meramente formale, ma si configura come una questione che attraversa la vita storica e le forme della relazione, interrogando in profondità le condizioni dell’agire umano e della convivenza. Attraverso un lavoro teorico capace di misurarsi con i punti di attrito tra norma ed esperienza, tali autrici hanno elaborato strumenti concettuali che consentono di pensare la giustizia nella sua densità teoretica, morale e politica, senza ridurla a un principio astratto o a un dispositivo tecnico.
Hannah Arendt, Simone Weil, Judith Butler, Judith Shklar, Sarah Kofman, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch, Martha Nussbaum e Susan Sontag: un quadro in cui trovano spazio figure centrali del Novecento, accanto ad autrici meno canonizzate e traiettorie di ricezione rimaste marginali, nella convinzione che la giustizia non possa essere pensata come un principio autosufficiente, ma come l’esito sempre provvisorio di un dialogo incessante e di un pensiero di concerto, capace di attraversare la norma, di interrogarne i limiti e di misurarsi con ciò che, nell’esperienza vissuta, resiste a ogni piena formalizzazione.